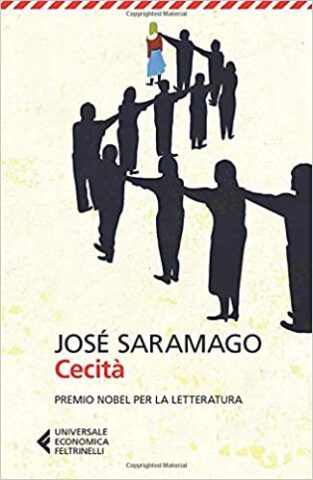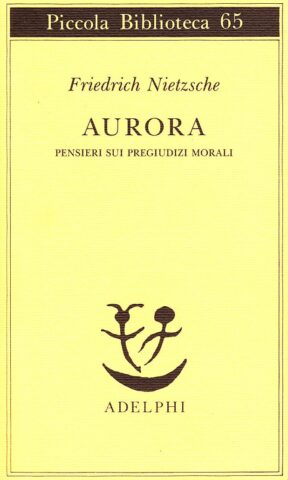L’Uomo che barattò il proprio Romanzo con la Vita (Parte II)
 Non appena giunse nella sua dimora, prese la corrispondenza: le solite cartoline scacchistiche. Davanti alla porta, sull’uscio di due mondi, dette una scorsa alle mosse, rincasò, si diresse nella camera da letto, poggiò sul comodino le cartoline bianche e nere, dopo si tolse la giacca, indossò un comodo maglione e caldo, riprese le cartoline e andò nello studio a riporle sul tavolinetto accanto alla finestra, uscì immediatamente dopo e si diresse in cucina, dove si preparò da mangiare e si sedette a tavola con l’usuale fame noncurante, la stessa che potrebbe avere un ateo alla mensa di Dio.
Non appena giunse nella sua dimora, prese la corrispondenza: le solite cartoline scacchistiche. Davanti alla porta, sull’uscio di due mondi, dette una scorsa alle mosse, rincasò, si diresse nella camera da letto, poggiò sul comodino le cartoline bianche e nere, dopo si tolse la giacca, indossò un comodo maglione e caldo, riprese le cartoline e andò nello studio a riporle sul tavolinetto accanto alla finestra, uscì immediatamente dopo e si diresse in cucina, dove si preparò da mangiare e si sedette a tavola con l’usuale fame noncurante, la stessa che potrebbe avere un ateo alla mensa di Dio.
Ne è pienamente consapevole, Augusto lo sa – delle volte acutamente fin troppo bene – che non riceverà mai alcuna lettera in risposta alle sue. Fin tanto che mangia, però, deglutisce morsi di pane come fossero frantumi ostinati di speranza.
Dopo aver pranzato, sparecchiò la tavola, pulì con cura tutto, preparò il caffè, aspettò, spense la fiamma, ordinò su di un vassoio un piattino con due zollette di zucchero, una tazzina e un calice di Barolo. Riempì la tazzina con raffigurazioni cinesi quasi fino all’orlo e si trasferì nello studio, dove accese una seconda sigaretta, seduto di fronte alla scacchiera con scacchi francesi, posta sopra al tavolinetto accanto alla finestra, affacciata sulla strada.
Ambiguamente sorride dei suoi desideri – Manco fosse un dio greco, sorride e sorride.
Là Augusto se ne sta per ore senza memoria, giocando mosse lente come stagioni antartiche, scrivendo, su pezzettini di carta bianca, i pensieri che solcano la sua anima come rivoli di un ghiacciaio in disgelo; poi li lascia cadere giù, in mezzo alla strada, dall’alto, portati via dal vento, come piccoli uccellini con le ali ferite.
Chissà che qualcuno non vi trovi una vita da creare!
Alle sedici e trenta in punto, come tutti gli altri giorni che verranno, uscì dallo studio, attraversò il corridoio, prese il cappotto e l’indossò, aprì la porta e la richiuse, scese le scale, percorse la via principale, riattraversò la piazza – ancora esagonale. Alle diciassette si ritrovò dietro al banco del suo negozio di fiori e nulla, proprio nulla sarebbe cambiato, se quel giorno le venti e trenta fossero rintoccate come il solito orario di chiusura – alla stregua dell’inesorabile sorgere e risorgere dell’alba. Furono gli occhi di Clementina, invece, ridenti come un giorno di primavera fuori stagione, ad annunciare quelle inusuali ore.
Clementina aveva venti anni, i capelli corvini lunghissimi, la pelle di pesca bianca e due occhi sconfinati d’azzurro. Era la figlia del direttore dell’ufficio postale e si presentò, proprio mentre Augusto si accingeva a chiudere, con in mano un scatola piena di lettere. Non spiegò nulla, mise la scatola sul banco infiorato, parlò e parlò come fosse stata lei tutta l’esperienza, la realtà, il sogno, l’intima vita di Augusto. In un momento, poi, gli occhi la tradirono e dalle sue tumide labbra si confessò un timido:
“Perché?”
… Appassionato…
Il vecchio Augusto stette ad ascoltare, come un bimbo che non capisce il mondo dei grandi. Alla fine, proprio mentre stava componendo un mazzo di gardenie bianchissime, quella domanda gli si schiantò dentro al cuore, come se fosse una gioia impaziente di confidarsi, che si scioglie in un entusiasmo irrefrenabile di parole. Per prima cosa prese la composizione di gardenie e, con negli occhi una premura forte di una saggezza temprata in un mondo non degli uomini, lo regalò a colei che colorò i propri d’un umido luminescente sorriso…
Non la rivide mai più, dopo quella interminabile notte, quando la prese per mano e la portò sotto un cielo di stelle senza luna e, ininterrottamente, continuò a parlarle ed ascoltarne i pensieri – un’ubriacatura di esistenze confidate ad un luogo immobile in un tempo immemore.
Augusto continua ancora oggi, come ieri, a scrivere lunghe lettere senza indirizzo, in bei caratteri – A Mio Padre, Al Mio Amico, Al Mio Amore – Aveva immaginato che, a questo modo, avrebbe vissuto il protagonista del romanzo che, venti anni o poco più addietro, non aveva avuto animo di scrivere.
Già, un’illusione è non altro che la trama della realtà, quindi rimane all’uomo il narrarla, ovvero viverla con estrema coerenza. Una bruciatura dello spirito creare nella fucina del divenire.
Invecchiò di questi anni, Augusto: creandosi personaggio di una vita trovata nell’immaginazione, e mai dubitando di essere felice, poiché ha da confondere ogni apparir dell’alba con un sogno; ha da cucire indosso alla vita il più aderente abito dell’essere; ha da scrivere delle lettere per confidare ai suoi pensieri, a tutto intero il suo sentire che tutto quello che è diventato lo ha sempre, comunque e irrimediabilmente, voluto.
Così – semplicemente.

Blogger per diletto, Istruttore di scacchi per passione. Insegno le regole e le basi del gioco, con pazienza e metodo. Scrivo, leggo. Gioco per corrispondenza.


 Blogger per diletto, Istruttore di scacchi per passione. Insegno le regole e le basi del gioco, con pazienza e metodo. Scrivo, leggo. Gioco per corrispondenza.
Blogger per diletto, Istruttore di scacchi per passione. Insegno le regole e le basi del gioco, con pazienza e metodo. Scrivo, leggo. Gioco per corrispondenza.